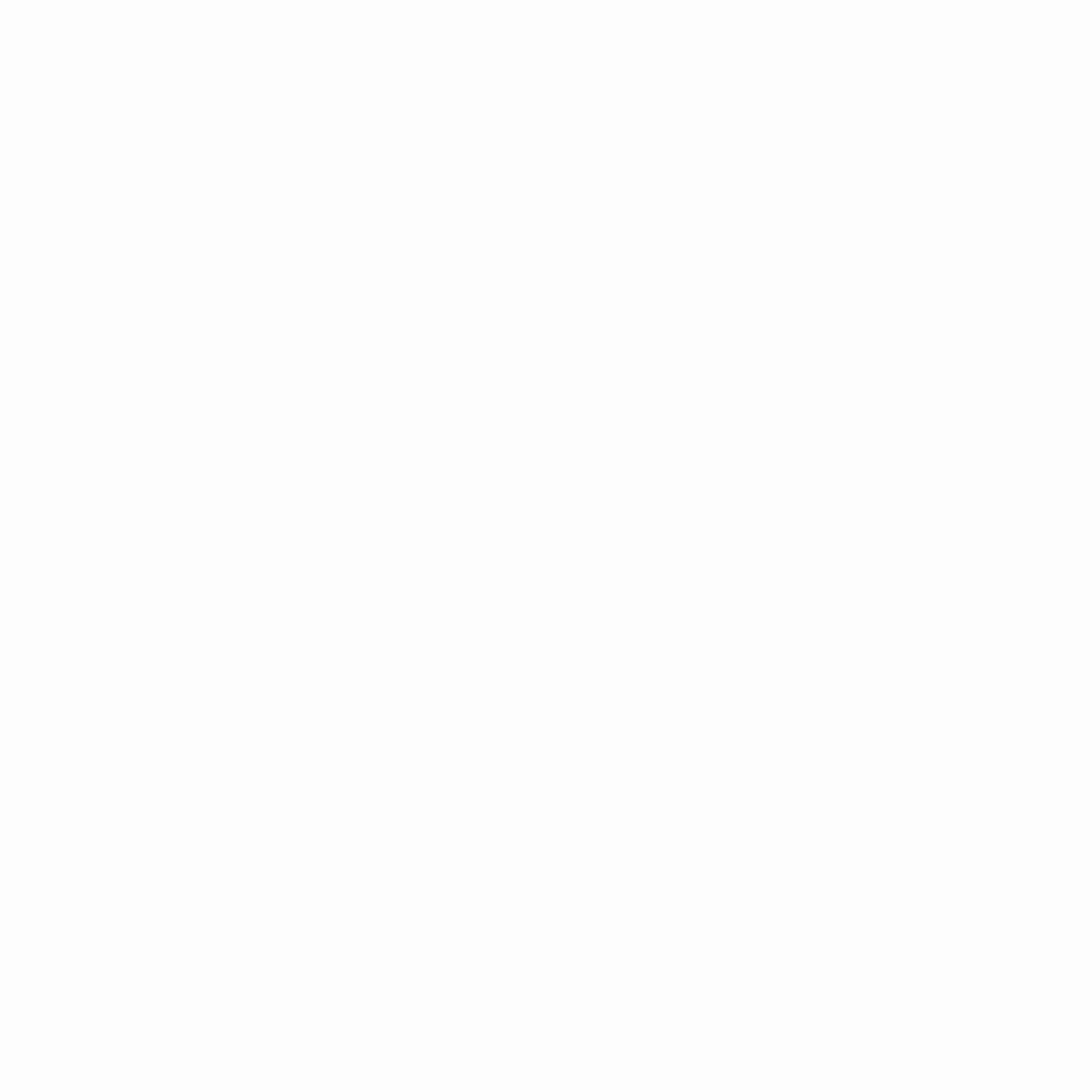Tino Brugnoli è allevatore e veterinario, e da tanto tempo fa sia l’uno e che l’altro. In certi anni è arrivato a seguire oltre 150 stalle, tutte rigorosamente da Parmigiano Reggiano. Eppure non è dalla bovina, ma dalle varietà d’erba tipiche di ogni area, e dal loro mix di polifenoli, che fa iniziare ogni storia di formaggio eccellente e con il sigillo unico del territorio da cui è nato.
“Dove si fa latte da Parmigiano Reggiano è ancora possibile una zootecnia che crea valore e lo distribuisce sul territorio. In particolare per la collina e la montagna, dove altrimenti resterebbe solo un’economia marginale. Certo, questo a una condizione: che la qualità del latte sia altissima e che il Parmigiano Reggiano sia quanto più possibile vicino al modello originario storico: giallo, profumato, dolce. Questo è legato a tanti fattori, certo, ma l’alimentazione conta per almeno l’80%. E i prati di collina e di montagna, dove negli anni si sono sviluppate innumerevoli varieta’ di erbe differenti, sono una ricchezza inestimabile da preservare e sviluppare, per preservare e sviluppare l’unicità e il valore del Parmigiano Reggiano”.
A dire questo è il dott. Tino Brugnoli, un “contadino” di montagna prestato alla veterinaria, come dice di sé stesso. Tino Brugnoli è infatti buiatra, con oltre trent’anni di libera professione tutta in stalle da Parmigiano Reggiano, ed è anche allevatore, con un allevamento di circa 360 capi e 180-200 vacche in mungitura. Certificato biologico dal primo gennaio 2000 è produttore di Parmigiano Reggiano, con un caseificio aziendale che tramite lattodotto riceve il latte direttamente dalla stalla.
Tino Brugnoli è anche un amante della sua terra, che non ha mai lasciato: siamo a Bardi, in Val di Ceno, quella parte di Appennino che dalla provincia di Parma va verso il mare della Liguria e che nei secoli – racconta – a saputo mantenere tanta, se non tutta, di quella ricchezza di ecotipi che, per fare un semplice esempio, fa contare ben cinquantatrè varietà diverse di orchidee selvatiche.
Dalle orchidee selvatiche della Val di Ceno come si arriva al Parmigiano Reggiano?
Ci si arriva, e anche facilmente. Nei prati e pascoli di queste montagne e di queste colline cresce un numero grandissimo di varietà di erbe. Miscugli che si sono formati negli anni e sono tipici per ogni fascia altimetrica. Qui siamo a 600 metri sul livello del mare, ma se salissimo a una quota superiore, anche di soli 200 metri, troveremmo altre composizioni, altre erbe. Varietà e tipicità che sono una ricchezza incredibile di polifenoli che dal latte passano al formaggio e danno gusto profumo, colore e dolcezza unici al Parmigiano Reggiano. Unici non per modo di dire, ma realmente, perché caratterizzano e legano profondamente quel formaggio al territorio dove è stato prodotto. È vero che tanti fattori entrano in gioco nel determinare le caratteristiche finali del Parmigiano Reggiano, ma l’alimentazione conta per non meno dell’80%. È quello che mangiano le vacche che fa la grande differenza. Quello che mangiano fissa anche in maniera indelebile il legame con un territorio unico. Questo vale sempre, ma per la collina e la montagna ancora di più. Per questo è fondamentale mettere grande attenzione alla produzione foraggera, ai prati e ai pascoli da cui si ricava il foraggio e, ogni volta che sia possibile, lavorare per migliorarli. Per farlo bisognerebbe selezionare un insieme di semi delle principali erbe dei nostri pascoli, che si sono adattate nel tempo, per poi procedere a seminarle (anche su sodo). Perché è da qui, dai prati, dai pascoli, dalle loro mille erbe, che parte la produzione di Parmigiano Reggiano, prima ancora che dalla stalla.
Il concetto vale anche per i medicai?
Qualcosa del genere andrebbe fatta anche per i medicai: puntare su varietà autoctone, adattatesi al territorio e capaci di resistere e produrre per più anni rispetto ai classici 3-4 di un medicaio. Certo, qui ci si scontra poi con il contenuto di lignina tendenzialmente più alto per queste varietà, per cui diventa ancora più importante la fase di raccolta. Però il discorso si riallaccia a quanto detto prima: il legame col territorio di un formaggio è anche il suo legame con erbe che su quel territorio hanno sempre vissuto.
Dai prati e dai pascoli della Val di Ceno entriamo ora nella stalla. E, dato che il nostro interlocutore è un esperto buiatra, il discorso non può che andare sull’aspetto sanitario. Il tema è caldo, con l’uso degli antibiotici da rivedere e rimodulare. Un percorso che da tempo il dott. Brugnoli ha impostato nella sua stalla e nelle stalle che segue, senza trascurare l’omeopatia. Insomma, il nuovo indirizzo non l’ha colto certo di sorpresa.
Non c’è dubbio che si debba porre grande attenzione all’uso degli antibiotici in allevamento. Perché non basta che non ci siano residui di una determinata molecola negli alimenti, ma – e qui andiamo nel campo della metabolomica – dobbiamo considerare che i metaboliti di quella molecola restano, per molto tempo, e possono anche rappresentare un pericolo. Quindi, su questo, non ci sono dubbi. L’antibiotico va usato con la massima prudenza e attenzione. A questo proposito, in un recente convegno, ricordo un’immagine originale che è stata proposta per indicare un possibile schema di approccio olistico alla malattia. L’immagine è quella della squadra di calcio schierata: in attacco ci sono fitoterapia ed omeopatia; a centrocampo: agopuntura e ayurveda, in difesa: cortisone e antinfiammatori; in porta, l’antibiotico. Solo alla fine, come nello schema calcistico, si dovrebbe arrivare all’antibiotico, come il portiere che è l’ultimo baluardo per evitare di subire una rete.
Questo vale anche per l’asciutta selettiva?
Certo, è fondamentale: l’antibiotico va usato solo sull’animale problema. E per fare la scelta corretta servono dati. Quelli delle cellule dati dal controllo funzionale, in primo luogo. Nel mio caso sotto le 300mila cellule, e senza mastiti cliniche durante la lattazione, uso solo un fitoterapico e il sigillante.
Avere in stalla animali resistenti e capaci di difendersi il più possibile dagli agenti esterni è la base di partenza per una mandria sana e con minimo utilizzo di farmaci. C’è una fase di allevamento dove a suo parere si può fare di più per avere migliori risultati?
Sono convinto che il lavoro maggiore da fare sia quello della preparazione delle manze, dalla vitellaia in avanti e con particolare attenzione alla fase successiva allo svezzamento. Qui la mia ricetta è una sola: dare spazio. Tanto spazio, più spazio possibile. Nel mio allevamento dopo una fase in gabbietta singola le vitelle sono messe in coppia nell’igloo e, subito dopo lo svezzamento, hanno a disposizione un ampio prato dove possono muoversi in gruppo con la massima libertà. Questi mesi di esercizio funzionale sono utilissimi per avere manze che crescano toniche e che arriveranno al parto senza problemi. E se il parto avviene naturalmente, senza alcun intervento da parte dell’eventuale assistente, questo è il punto di partenza giusto. Certo, alla prima lattazione sono magari meno produttive, ma il latte lo si recupera ampiamente in seguito, perché faranno poi più lattazioni.