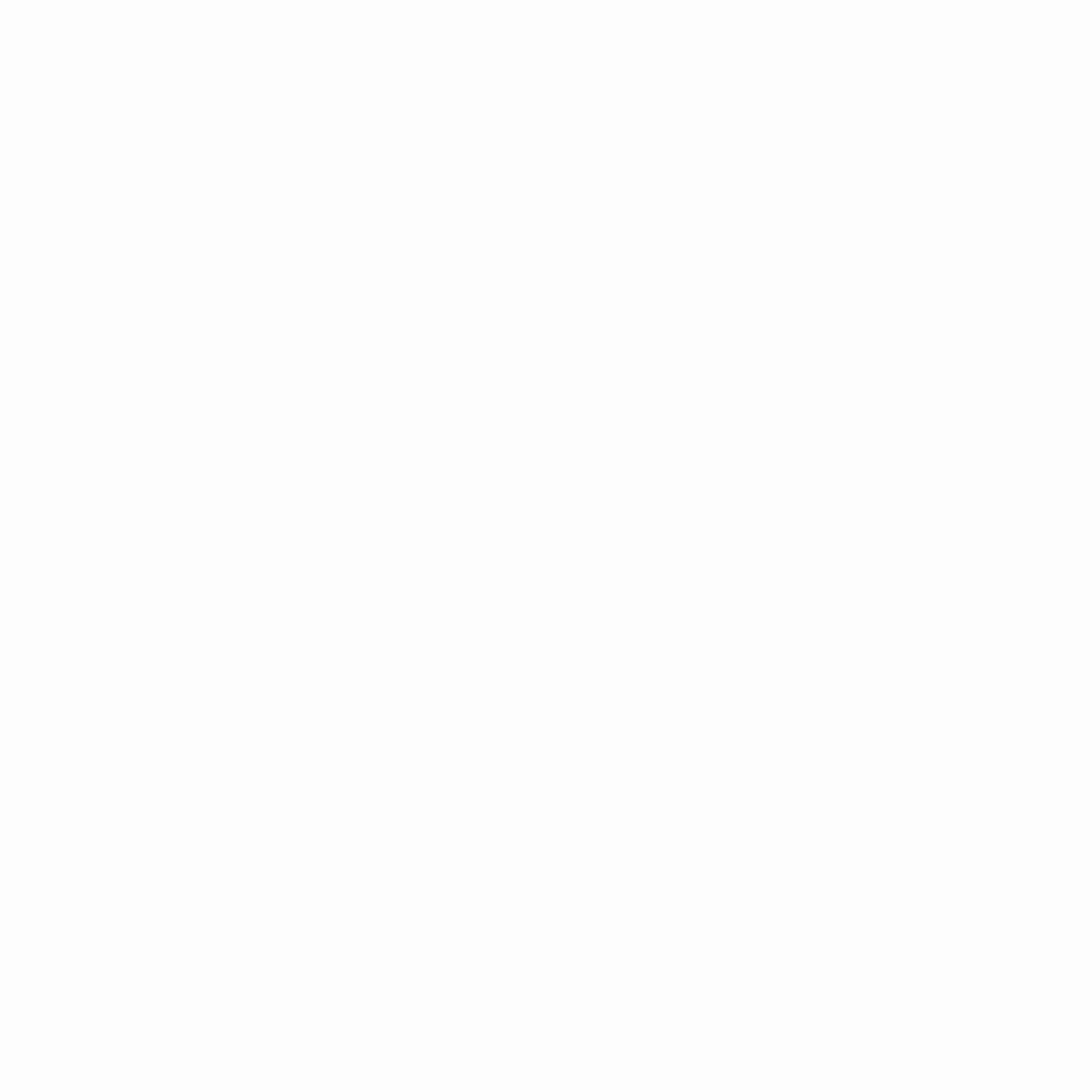L’urea nel latte resta un indicatore prezioso, ma la sua interpretazione richiede metodo e continuità.
È un parametro che racconta l’equilibrio tra l’azoto disponibile nella razione e i carboidrati fermentescibili, e che, se analizzato nel tempo, aiuta a valutare l’efficienza di utilizzazione dell’azoto e la coerenza della dieta con la fase produttiva della mandria.
Negli anni Novanta, l’attenzione verso l’urea nacque dal timore che valori elevati potessero influenzare negativamente la fertilità e il metabolismo delle bovine, in particolare nel periodo di picco produttivo.
Con il tempo, la ricerca e l’esperienza in stalla hanno ridimensionato quella preoccupazione, spostando l’interesse dal dato assoluto alla sua variabilità. Oggi il controllo dell’urea non serve più a diagnosticare “eccessi proteici”, ma a leggere l’efficienza del sistema alimentare.
L’articolo di Alessandro Fantini su Ruminantia rielabora una vasta base dati fornita da ANAFIBJ e AIA: oltre 82,8 milioni di rilievi raccolti tra il 2010 e il 2025 in allevamenti di Frisona italiana. L’analisi mostra che la distribuzione dei valori di urea nel latte individuale si è mantenuta stabile negli ultimi dieci anni, nonostante l’aumento delle produzioni di latte, grasso e proteine.
Nel periodo considerato, la quota di bovine con urea alta (>36 mg/dl) resta minoritaria, ma tende a crescere con l’avanzare della lattazione; la classe media (20–36 mg/dl) rappresenta oltre metà della popolazione e segue lo stesso andamento; la classe bassa (<20 mg/dl) varia tra il 25 e il 45% e diminuisce con i giorni dal parto.
Questi dati confermano che l’urea è influenzata più dalla fisiologia della bovina e dall’andamento della lattazione che da un singolo elemento della dieta.
Per l’allevatore, l’informazione più utile non è quindi il valore medio di massa, ma l’urea individuale, da osservare soprattutto nelle prime settimane post-parto. Se oltre il 10–15% delle bovine “fresche” supera i 36 mg/dl o scende sotto i 20 mg/dl, il sistema alimentare merita una verifica: gli squilibri possono dipendere da un eccesso di azoto rapidamente degradabile o da una carenza di energia fermentescibile, con ricadute sul metabolismo e sulla fertilità.
Nel sistema produttivo del Parmigiano Reggiano, il controllo dell’urea assume un rilievo ulteriore. Le restrizioni del disciplinare sull’uso dei foraggi e la limitata disponibilità di azoto solubile rendono il bilanciamento della razione ancora più delicato.
In questi contesti, monitorare l’urea del latte — sia di massa sia individuale — permette di individuare per tempo deviazioni che potrebbero compromettere l’efficienza produttiva o la qualità del latte destinato alla trasformazione.
L’urea resta quindi un parametro utile, ma da interpretare nel contesto della mandria, della stagione e della dieta.
Sintesi dell’articolo di Alessandro Fantini pubblicato su Ruminantia (20 ottobre 2025), realizzato in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano.