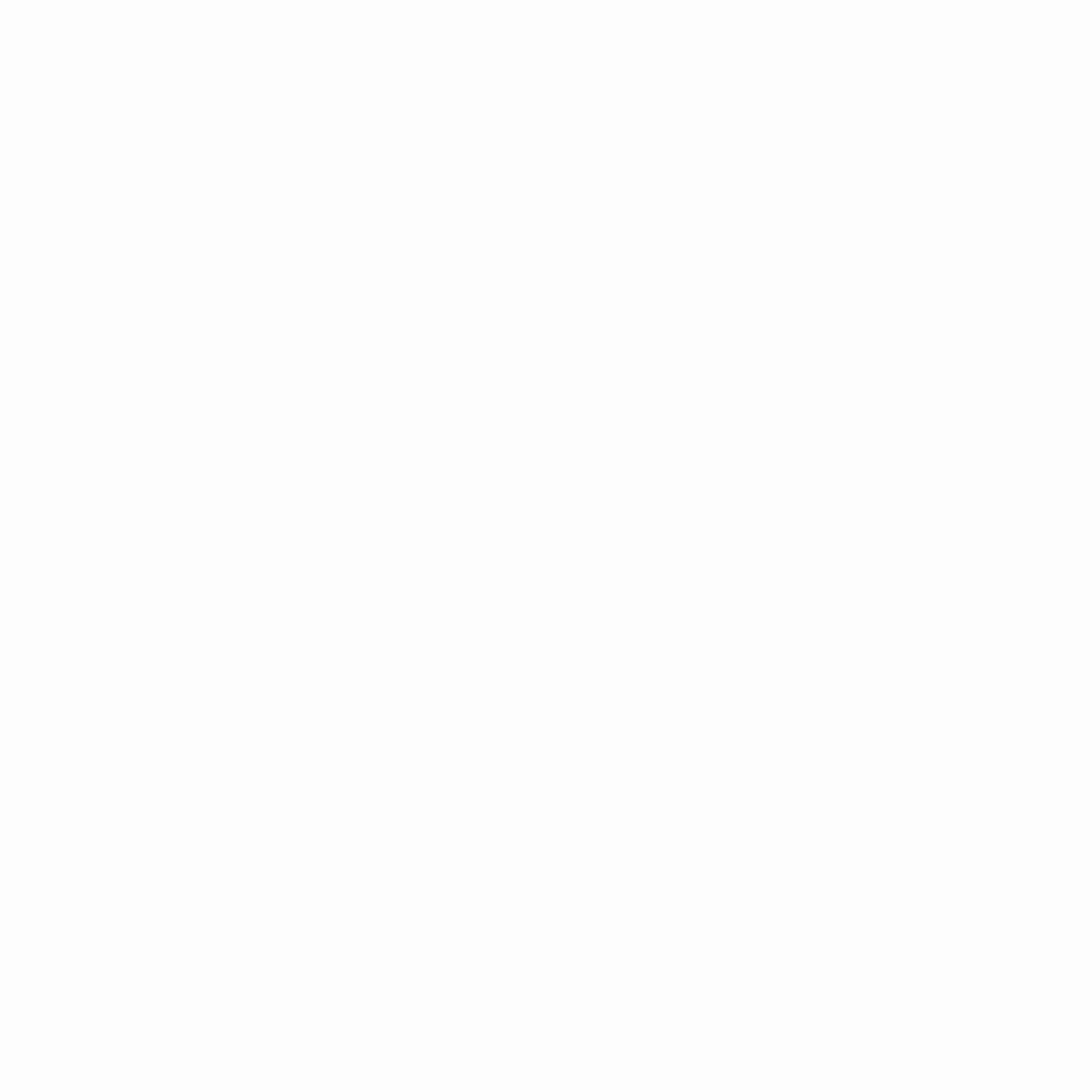Negli allevamenti da latte destinati alla produzione di Parmigiano Reggiano ogni dettaglio conta. Anche aspetti apparentemente secondari come il controllo delle mosche influenzano direttamente la sanità della mandria, il benessere delle bovine e l’immagine stessa dell’azienda agricola verso il consumatore finale.
Le mosche, infatti non sono semplici fastidi estivi.
La loro presenza incontrollata può diventare un problema tecnico serio, capace di compromettere la qualità del latte, aumentare il rischio di patologie, incidere negativamente sull’efficienza produttiva e ridurre il valore percepito della stalla dal punto di vista del benessere animale.
Rischi sanitari: un nemico spesso sottovalutato
Le mosche, in particolare la mosca domestica (Musca domestica) e la mosca pungente (Stomoxys calcitrans), rappresentano una minaccia significativa per la salute delle bovine da latte. Oltre al fastidio fisico, queste specie sono vettori meccanici e biologici di numerosi patogeni che possono compromettere la sanità della mandria e la qualità del latte prodotto.
Le mosche possono trasportare batteri patogeni sia esternamente, sulle zampe e sul corpo, sia internamente, attraverso l’apparato digerente. Posandosi su ferite, capezzoli, alimenti o attrezzature di mungitura, possono trasferire microrganismi come Escherichia coli, Salmonella spp., Listeria monocytogenes e Staphylococcus aureus. Questi agenti patogeni sono direttamente implicati in infezioni ambientali della mammella, enteriti, infezioni respiratorie nei vitelli e altre patologie subcliniche.
In particolare, Stomoxys calcitrans è stato identificato come vettore di Staphylococcus aureus, un batterio responsabile di mastiti ambientali nelle bovine da latte. Studi recenti hanno dimostrato che queste mosche possono ingerire il batterio durante un pasto di sangue infetto e trasmetterlo successivamente a un altro animale attraverso un nuovo pasto, creando un ciclo di infezione che può diffondersi rapidamente all’interno della mandria.
La presenza di mosche è stata correlata a un aumento dell’incidenza di mastiti ambientali. Le mosche possono introdurre batteri patogeni direttamente nel canale del capezzolo o attraverso microlesioni cutanee, facilitando l’insorgenza di infezioni. Inoltre, la loro attività può interferire con le pratiche di mungitura, aumentando il rischio di contaminazione del latte e compromettendo la qualità del prodotto finale.
I vitelli sono particolarmente vulnerabili alla trasmissione di patogeni da parte delle mosche. La contaminazione degli alimenti e dell’ambiente da parte di mosche infette può portare a infezioni gastrointestinali e respiratorie nei giovani animali, con conseguenti ritardi nella crescita, aumento della mortalità e necessità di trattamenti antibiotici. Questi effetti non solo compromettono il benessere degli animali, ma possono anche avere ripercussioni economiche significative per l’allevamento.
Le mosche possono contribuire anche alla diffusione di batteri resistenti agli antibiotici all’interno della mandria. Trasportando e diffondendo ceppi batterici resistenti, possono rendere più difficile il trattamento delle infezioni e aumentare la pressione selettiva per lo sviluppo di ulteriori resistenze. Questo fenomeno rappresenta una sfida crescente per la salute animale e la sicurezza alimentare.
Benessere animale compromesso
Il fastidio provocato dalle mosche non si limita all’irritazione locale. Le bovine infastidite modificano profondamente il loro comportamento: aumentano i movimenti di difesa (colpi di coda, scalciate, scuotimenti della testa), riducono il tempo di riposo nelle cuccette, diminuiscono il tempo di ingestione alla mangiatoia e mostrano segni evidenti di stress.
Questo aumento dell’attività non produttiva comporta un maggior dispendio energetico, una riduzione dell’efficienza alimentare e un incremento della secrezione di cortisolo, ormone dello stress. Conseguentemente si osservano: riduzione della produzione giornaliera di latte; peggioramento dell’efficienza di conversione alimentare; allungamento degli intervalli interparto; aumento delle problematiche metaboliche e infiammatorie subcliniche.
Come costruire un piano efficace di contrasto alle mosche
Affrontare il problema in modo sistematico richiede un approccio integrato, strutturato su tre livelli.
1. Prevenzione ambientale. La prima barriera è costituita da una gestione ambientale accurata. Le mosche si sviluppano in substrati umidi e ricchi di sostanza organica. Occorre quindi rimuovere tempestivamente i residui di razione; mantenere pulite il più possibile asciutte le corsie e le aree di abbeverata; gestire correttamente le concimaie, evitando accumuli non protetti; asciugare rapidamente eventuali ristagni d’acqua; curare la pulizia e la manutenzione delle cuccette. Una buona gestione igienica riduce drasticamente i siti idonei alla deposizione delle uova, limitando lo sviluppo delle larve.
2. Monitoraggio regolare. Non si può gestire ciò che non si misura. È fondamentale monitorare costantemente la presenza di mosche attraverso: trappole attrattive conta-insetti posizionate in punti strategici; osservazioni visive quotidiane; rilevazione precoce di variazioni nei comportamenti animali (meno tempo sdraiati, ingestione ridotta, agitazione in corsia). Il monitoraggio consente di programmare gli interventi prima che l’infestazione diventi sistemica.
3. Interventi mirati e integrati. Gli interventi devono combinare diverse strategie: trattamenti larvicidi (biologici o chimici) nei siti di sviluppo delle larve; uso di predatori naturali (parassitoidi come Muscidifurax e Spalangia) per il controllo biologico; impiego selettivo di adulticidi solo nei casi di emergenza, preferendo prodotti a basso impatto ambientale e seguendo strategie di rotazione per prevenire resistenze; i sistemi di ventilazione forzata disturbano il volo e rendono più difficoltoso l’accoppiamento e la deposizione.
Ogni programma di controllo deve essere mantenuto costante lungo tutta la stagione favorevole allo sviluppo delle mosche (primavera-inizio autunno), adattandosi alle condizioni climatiche e alla tipologia aziendale.
Una gestione seria della biosicurezza passa anche dal controllo delle mosche
Nel contesto della filiera del Parmigiano Reggiano, dove il rispetto dei requisiti sanitari e di benessere animale è essenziale, la lotta alle mosche assume un ruolo tecnico primario È un elemento che si inserisce nella costruzione quotidiana della sanità di mandria, nella protezione della qualità del latte e nella tutela dell’immagine aziendale verso il mercato e il consumatore.
Controllare le mosche significa proteggere la mandria, migliorare il benessere animale e rafforzare la reputazione dell’allevamento. Un buon piano di lotta alle mosche è quindi un investimento a tutti gli effetti, che guarda alla stalla e anche al consumatore.