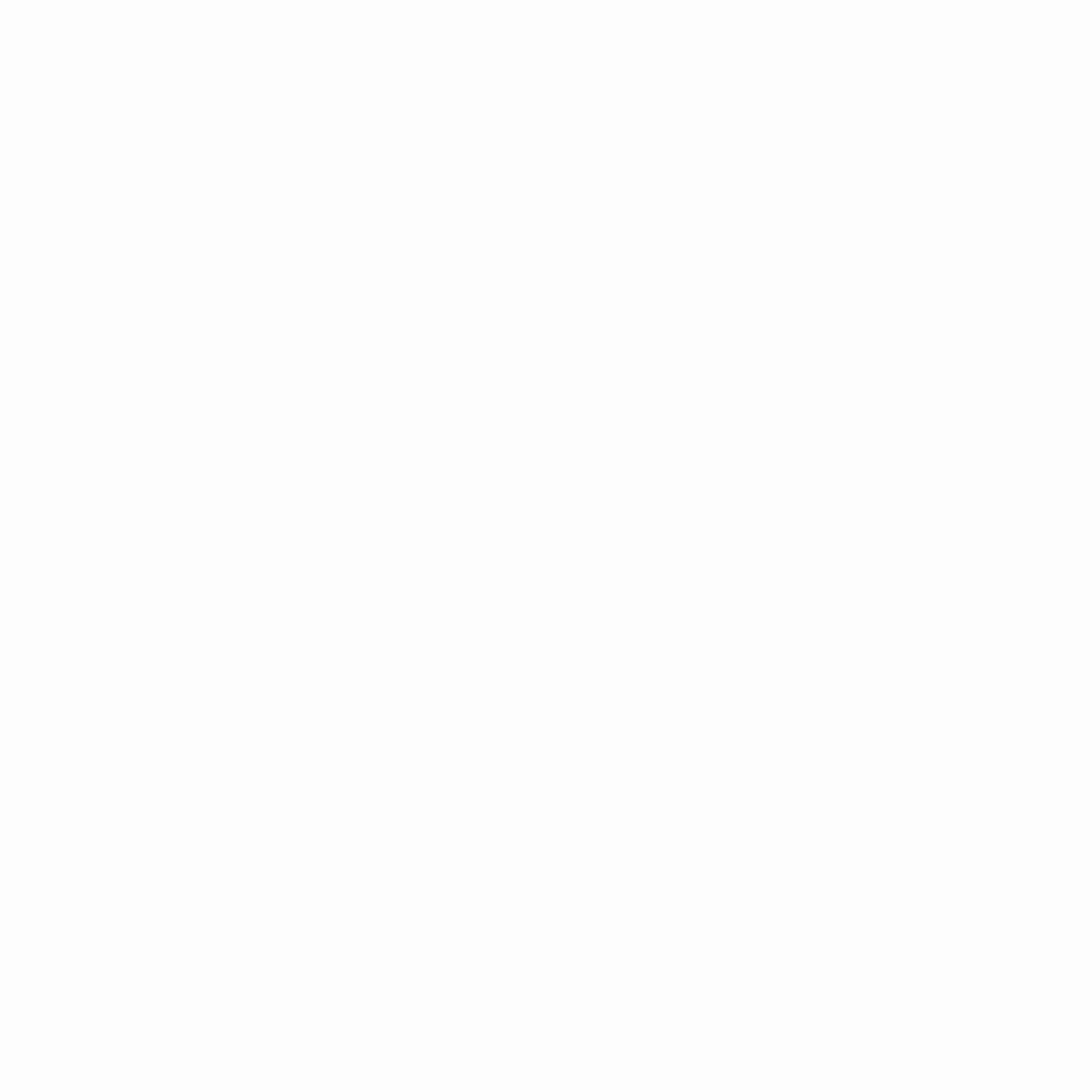Per anni si è misurato il benessere animale soprattutto con una visuale “al negativo”, e cioè con l’obiettivo di ridurre al minimo eventi e situazioni non positive. E quindi: assenza di fame, di sete, di dolore, di paura, di condizioni igieniche insufficienti e così via. Questo è andato via via definendosi e affermandosi in check list e protocolli a tutti noti.
Oggi la discussione, senza con questo disconoscere i meriti del percorso fatto in questi anni, sta cambiando prospettiva: dall’evitare il disagio al progettare e riconoscere esperienze positive.
Significa in concreto spostare il baricentro dall’adempimento alla qualità di vita: un cambio di mentalità che spinge a guardare la stalla con un’altra lente—quella delle emozioni, delle motivazioni e delle relazioni che gli animali esprimono quando l’ambiente glielo consente.
Cosa fanno gli animali quando stanno bene
Il primo indizio di benessere positivo è a portata d’occhio: il comportamento spontaneo. L’allogrooming — le leccate reciproche sul collo o sul garrese tra animali consenzienti — non è solo “pulizia”: è affiliazione, fiducia, rilassamento del gruppo. Se in stalla si osservano episodi regolari, sappiamo che lo spazio, i tempi e la coesione sociale stanno lavorando nella direzione giusta.
Lo stesso vale per il gioco. Nei vitelli lo riconosciamo facilmente (saltelli, corse, movimenti del capo “a vuoto”); ma, quando le condizioni sono davvero favorevoli, compaiono sequenze ludiche anche nelle vacche adulte. Il gioco è quello che si può definire un lusso biologico: emerge solo quando bisogni primari, comfort e sicurezza sono soddisfatti. È la prova che l’animale “ha margine” e può dedicare energia a qualcosa che non serve a sopravvivere, ma a stare bene.
C’è poi l’esplorazione: curiosare senza scopo immediato, annusare, toccare, attraversare un passaggio. È il segno di un reale margine di scelta e controllo dell’animale sul proprio ambiente. Dove gli animali possono decidere quando e con chi interagire, dove sdraiarsi, quando alimentarsi, l’insieme dei comportamenti si fa più vario e “positivo”.
Anche le posture e i microsegnali contano: la ruminazione distesa con arti allungati e occhi socchiusi racconta comfort; orecchie pendenti e sguardo morbido indicano bassa attivazione; l’assenza di stereotipie e una routine flessibile (gioco–interazione–esplorazione–riposo–alimentazione) confermano che l’animale vive in un contesto favorevole.
Non solo etologia: cosa possiamo (e non possiamo) misurare oggi
Accanto all’osservazione, la ricerca ha aperto strade fisiologiche e neurobiologiche. La variabilità della frequenza cardiaca (HRV) fotografa l’equilibrio del sistema nervoso autonomo e, in condizioni di riposo, si associa a rilassamento; l’ossitocina cresce con interazioni sociali positive o contatti calmi con l’operatore; l’EEG in ambienti controllati mostra pattern coerenti con stati gratificanti. Sono spunti solidi, ma—per costi, strumentazione e standardizzazione—oggi restano soprattutto da laboratorio. Il messaggio pratico è quindi chiaro: la bussola in azienda resta il comportamento, letto con metodo e contesto.
L’ambiente come generatore di emozioni positive
Il benessere animale positivo non nasce “togliendo problemi” (questo è il cambio di mentalità) ma creando opportunità. Il pascolo, quando disponibile, è la condizione più completa: libertà motoria, ampia possibilità di scelta, stimolazione sensoriale. Nei sistemi indoor, la chiave è avvicinarsi a quel modello: lettiere profonde, asciutte e confortevoli che invitino alla ruminazione distesa; ventilazione e luce adeguate; superfici antiscivolo e percorsi larghi per ridurre conflitti e incertezze; rumore sotto controllo. Gli arricchimenti—spazzole, balle da esplorare, piccoli oggetti—stimolano a loro volta interazione e curiosità.
Poi c’è la relazione uomo–animale. Sequenze brevi e amichevoli di contatto positivo, specie nelle prime fasi di vita del vitello, lasciano tracce: più docilità, meno reattività, routine più stabili. Voce, postura, ritmo dei movimenti, prevedibilità: sono dettagli che dal punto di vista dell’animale fanno la differenza tra “tollerare” e “fidarsi”.
Perché interessa a chi fa latte per Parmigiano Reggiano
Per una filiera come quella del Parmigiano Reggiano il benessere animale positivo non è un vezzo teorico: è un modo nuovo—più completo e dimostrabile—di far coincidere gestione di stalla, identità della DOP e aspettative del mercato. Quando gli animali mostrano comportamenti sociali sereni, non stiamo solo “evitando problemi”: stiamo costruendo condizioni che si riflettono su parametri produttivi e sanitari più stabili. Nel tempo questo significa mandrie più longeve e resilienti.
C’è poi un tema di coerenza e trasparenza. Il Parmigiano Reggiano è anche un racconto di prati, medica, territorio, benessere: integrare la lettura dei segnali positivi—grooming, gioco, posture di comfort, espressioni facciali rilassate—aggiunge conferme a questa narrazione. Indicatori di “presenza” che si possono documentare con schede leggere, filmati brevi, trend di osservazione. È un linguaggio comprensibile a buyer e consumatori, e fornisce evidenze utili nelle verifiche di filiera e nei report di sostenibilità.