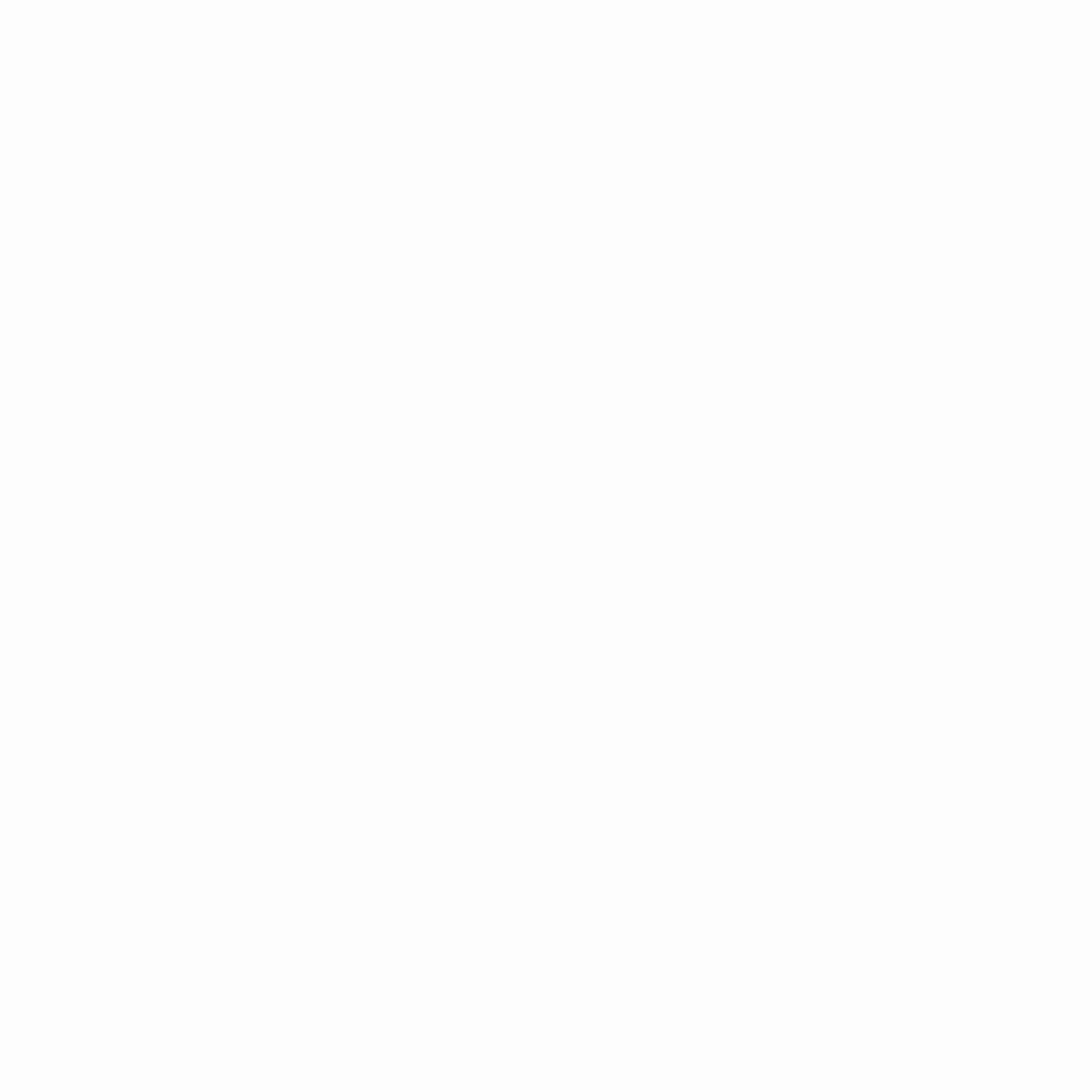Parlare di sostenibilità nella filiera del Parmigiano Reggiano significa, da sempre, parlare di latte e foraggi. Ma in un contesto in cui le filiere alimentari sono chiamate a rendicontare il loro impatto in modo sempre più dettagliato, entra in gioco un indicatore che finora è rimasto in ombra: l’impronta fondiaria, ovvero la superficie agricola necessaria per produrre 1 kg di latte corretto per grasso e proteina (FPCM), considerando sia i terreni aziendali sia quelli impiegati, spesso altrove, per produrre i mangimi acquistati.
Un recente studio condotto in Piemonte dall’Università di Torino e pubblicato su JDS (Comparison of frameworks for defining land occupation considering on-farm and off-farm feed production on Italian dairy farms) ha messo in luce la grande variabilità di questo parametro tra aziende da latte con strategie gestionali differenti. Le stalle che autoproducono più foraggi proteici, come la medica, risultano significativamente più efficienti sul piano dell’uso del suolo: hanno bisogno di meno terra, anche lontana, per sostenere la propria produzione. Al contrario, l’affidamento a mangimi proteici acquistati, come la soia, aumenta l’impronta fondiaria, spostando in media circa l’83% della LO off-farm sulla sola componente proteica (soia), mentre la parte energetica (mais) pesa attorno al 17%.
Leguminose foraggere, un punto di forza
Lo studio piemontese dimostra come le aziende che coltivano alti quantitativi di leguminose foraggere riducano l’uso di superfici esterne grazie a una maggiore autosufficienza proteica. Si tratta di una leva cruciale per ridurre l’impronta fondiaria, e quindi per abbassare la pressione che l’allevamento esercita su terreni agricoli potenzialmente destinabili a colture per l’alimentazione umana. Nel comprensorio del Parmigiano Reggiano, dove la medica di qualità è già parte integrante dei piani foraggeri, questo elemento si trasforma in vantaggio competitivo: il latte viene prodotto con una base proteica locale, rinnovabile e a basso impatto, in linea con i criteri della sostenibilità agricola più avanzata.
Prati permanenti e uso del suolo: una risorsa strategica
Un altro elemento chiave emerso dallo studio è il ruolo dei prati permanenti. In molte aziende piemontesi, questi ambienti contribuiscono a ridurre l’impronta fondiaria complessiva, in quanto non entrano in competizione diretta con la produzione di alimenti destinati all’uomo. Se si esclude questa quota di superficie non arabile dal calcolo, l’impronta fondiaria di alcune aziende si riduce del 64–70%. Questo dato rafforza la posizione del Parmigiano Reggiano, che trova nei prati stabili del comprensorio un tratto distintivo della propria identità agricola. I prati permanenti, oltre a garantire continuità foraggera e qualità della razione, offrono servizi ecosistemici come la tutela della biodiversità, il sequestro di carbonio organico nel suolo e la stabilità idrologica dei versanti. Inseriti nel contesto di un sistema produttivo regolato da un disciplinare rigoroso, diventano parte integrante della narrazione ambientale della DOP.
Un uso più efficiente della terra come leva di filiera
L’analisi piemontese, pur riferita a un contesto diverso, offre spunti diretti anche per le stalle del Parmigiano Reggiano. Uno dei messaggi più chiari è che più foraggio si produce in azienda, minore è la dipendenza da fonti esterne e più contenuta è la superficie complessiva necessaria a produrre il latte. È un dato semplice, ma con forti implicazioni pratiche: in un’economia globale che mette sempre più in competizione allevamento e agricoltura per l’uso del suolo, l’autosufficienza foraggera diventa un indicatore ambientale oltre che tecnico. Nel contesto del Parmigiano Reggiano, dove la razione è già fortemente centrata su foraggi aziendali, i margini di miglioramento si spostano dal “quanto” al “come”. A fare la differenza è soprattutto la qualità della produzione foraggera, a partire da una gestione più attenta dei prati permanenti e dei pascoli, passando per la scelta di varietà di medica più produttive e resistenti, fino all’introduzione, dove necessario, di specie alternative come sorgo o girasole. Anche la pianificazione delle rotazioni, l’impiego ragionato dell’irrigazione e l’adozione di tecniche conservative contribuiscono a massimizzare la resa foraggera per ettaro.
Gestione dei nutrienti: una questione di equilibrio
Lo studio piemontese associa l’impronta fondiaria al bilancio dell’azoto, evidenziando che le aziende con più mangimi acquistati tendono ad accumulare maggiori surplus azotati: correlazioni positive tra LO off-farm e surplus N (r = 0,45–0,73) e surplus medio di 355 kg N/ha (con picchi ben più elevati nelle aziende più intensive). Nella filiera del Parmigiano Reggiano questa relazione aumenta la virtuosità dell’approccio: migliorare la programmazione foraggera, ridurre il ricorso a proteine esterne e gestire in modo coordinato fertilizzazioni e razioni può portare benefici concreti, sia sul piano agronomico che su quello ambientale. Senza semplificare il tema, emerge un principio utile: più si produce “in casa”, più si controlla l’equilibrio del sistema.
Sostenibilità visibile: un’opportunità per la DOP
Il Parmigiano Reggiano è da sempre un modello di filiera corta, foraggiera e territoriale. Anche l’introduzione di strumenti come l’impronta fondiaria permette oggi di dare visibilità tecnica a questi punti di forza. In un tempo in cui si chiede agli allevamenti di rendere conto del proprio impatto, poter dimostrare che il latte PR nasce da sistemi che usano meno suolo esterno, che si basano su leguminose locali, e che valorizzano prati permanenti storici, è un’opportunità anche in termini di comunicazione di filiera: il Parmigiano Reggiano, per sua natura, non solo rispetta un disciplinare rigoroso, ma lo fa anche con un’impronta territoriale e ambientale tra le più virtuose nel panorama delle DOP.