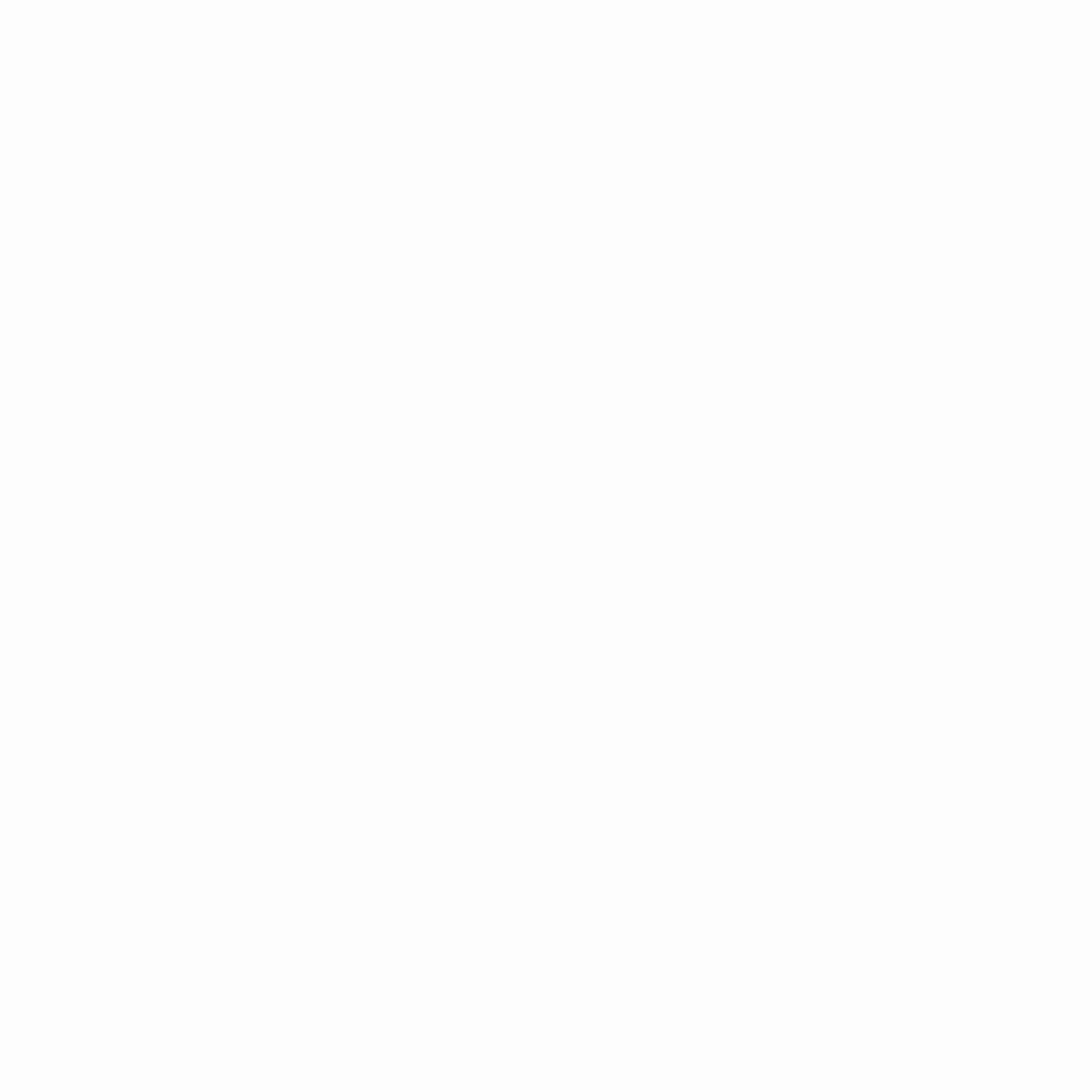Quando pensiamo a che cosa fa girare la mandria, la mente corre subito a proteina, amido, fibra, energia. Ma prima di ogni cosa viene l’ingestione di sostanza secca (DMI): senza “chilogrammi in bocca”, nessun bilancio nutritivo regge. È il messaggio centrale dell’approfondimento di Alessandro Fantini pubblicato su Ruminantia e dedicato ai temi tecnici più importanti dell’allevamento da Parmigiano Reggiano. L’articolo (clicca qui) mette in fila numeri e ragioni tecniche per considerare l’ingestione il fenotipo prioritario, da misurare, gestire e migliorare con metodo.
Perché i chili contano più delle percentuali
L’articolo parte da un esempio. Una razione al 16% di proteina e 26% di amido fornisce, con 25 kg di SS, 4.000 g di proteina e 6.500 g di amido. Se la stessa razione viene mangiata a 27,5 kg, l’animale incamera +400 g di proteina e +650 g di amido al giorno. Nessun trucco di formulazione: solo più ingestione.
Provate a fare il percorso opposto. Se per vari motivi la bovina resta ferma a 25 kg di SS, per avere quegli stessi 4.400 g di proteina e 7.150 g di amido bisognerebbe alzare la densità al 17,6% di proteina e 28,6% di amido. Sulla carta si può; in corsia, però, si paga il conto: fibra fisicamente efficace che si assottiglia, rischio di selezione e acidosi ruminale subacuta (SARA) più vicino. In altre parole, le percentuali lavorano bene solo se reggono i chilogrammi. Ed è qui che l’ingestione torna a essere la leva più pulita e sicura.
Quanta SS “dovrebbe” entrare? I riferimenti che servono davvero
Come bussola di campo, l’articolo richiama i valori NASEM. Una Frisona primipara di 570 kg a 150 di lattazione ha un fabbisogno tipico di 23,9 kg di SS (≈ 4,2% del peso vivo). Una Frisona matura di 700 kg a 100 DIM sale a 29,4 kg di SS (sempre ≈ 4,2% del PV). Sono ordini di grandezza utili per capire se il gruppo si sta muovendo dove deve.
Sulla fibra, vale ancora la “regola storica”: la NDF ingerita si colloca intorno a 1,2% del PV (con un massimo operativo ≈ 1,5%). Per una bovina da 700 kg significa ~9,0 kg di NDF (tetto massimo ~10,7 kg). Attenzione: è una stima di insieme, che non distingue tra NDF da foraggi e NDF “concentrata”; la struttura dipende dalla fibra fisicamente efficace. Per le fresche, il pezzo chiave è la uNDF (frazione indigeribile della NDF): lo spazio “che occupa” nel rumine. Le forchette operative indicate sono 0,29–0,35% del PV oppure 9–11% della SS di razione.
Non solo riempimento: i freni metabolici all’appetito
Non è tutto meccanica. La teoria dell’ossidazione epatica (Allen) ricorda che i propionati prodotti dalla fermentazione dell’amido inibiscono l’appetito via fegato: razioni molto amidacee possono saziare prima a parità di megacalorie. È uno dei motivi per cui, inseguendo la densità, a volte si mangia meno. La soluzione non è demonizzare l’amido, ma distribuirlo bene tra fonti, tempi di rilascio e gestione alla mangiatoia.
Acqua, appetibilità, comfort: le tre “banalità” che spostano l’ago
Se l’obiettivo è far salire (o non perdere) DMI, tre voci “banali” valgono più di molti dettagli.
Acqua. In condizioni normali una bovina da latte beve ~78,4 ± 2,6 kg/giorno; ~60% dell’assunzione arriva subito dopo la mungitura. Misurate con contalitri e controllate qualità (durezza, odore/sapore, pH, sodio, solfati, ferro): poca acqua o acqua “sgradita” valgono come una dieta peggiore. Verificate portata e accessibilità a tutte le ore—specie d’estate.
Appetibilità. Micotossine, rancidità, fermentazioni difettose tagliano l’ingestione. Il sospetto si scioglie con due mosse semplici: analitiche mirate e prove pratiche (offrire il foraggio “incriminato” a soggetti non in lattazione e osservare il rifiuto). Nulla fa scendere l’ingestione come un odore cattivo.
Comfort e gestione di corsia. Spingere l’unifeed più volte al giorno, evitare “finestre vuote” alla mangiatoia, omogeneità di miscelazione, umidità corretta della TMR, spazio e ventilazione adeguati: sono dettagli che si sommano in chili. Nei gruppi “a rischio” (fresche, alte produzioni), la coerenza dei ritmi fa mezz’ora di ruminazione al giorno a testa—e spesso un chilogrammo di SS in più.
Misurare, confrontare, reagire
Qui arriva la parte operativa. Non basta “immaginare” l’ingestione: va misurata. La formula è semplice: SS somministrata – scarti ± integrazioni (robot o autoalimentatori). Il controllo minimo è settimanale e dopo ogni cambio di razione o lotto foraggero; il confronto va fatto con la media del periodo, con lo stesso mese dell’anno precedente e con le stime dei modelli. Suggerimento utile dove si fa TMR “a gruppo unico”: usare i giorni di controllo funzionale per un benchmark puntuale tra gruppi e lungo l’anno.
Il senso di insieme
Migliorare l’ingestione non è “solo” aggiungere un chilo di SS: è spostare la mandria su un piano di stabilità (meno oscillazioni tra giorni e tra turni), salute ruminale (meno SARA di ritorno), resa (più nutrienti realmente disponibili senza forzare le percentuali) e resistenza agli stress (caldo incluso). Di qui il messaggio pratico con cui si chiude l’articolo di Alessandro Fantini: misurate l’ingestione, presidiate l’acqua, curate appetibilità e struttura, e usate i numeri per intervenire presto. Tutto il resto seguirà di conseguenza.